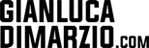Un vescovo romano del III secolo, Tascio Cecilio Cipriano, sosteneva che “fuori dalla Chiesa, non c’è salvezza”. Quasi un paio di millenni dopo, la Siena del calcio, si sarebbe ritrovata ad annuire di fronte a un’affermazione molto simile: “fuori Chiesa, non c’è salvezza”. Cross tagliato dal sacro al profano, concetti ed epoche diverse, conclusioni simili.
Perché se esiste un pantheon del pallone senese, Enrico Chiesa è di sicuro in prima fila. Arrivato nel 2003 in una squadra neopromossa e rimasto per cinque stagioni: 134 presenze, 33 esultanze, condivise con un popolo che gli ha voluto bene al primo sguardo e che con lui in campo non è mai retrocesso. “Una piccola storia di sano calcio di provincia. Eravamo come una famiglia capace di affrontare le grandi difficoltà della serie A”, ricorda il bomber genovese ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Un giocatore capace di segnare 139 reti in carriera, più di Pruzzo o Vialli, per intenderci.
Un uomo a cui la tifoseria senese ha intitolato il primo e unico club dedicato a un calciatore, “È vero, per me è un attestato di stima splendido. Il riconoscimento di cinque anni importanti. Perché per le nostre possibilità, ogni salvezza era un piccolo scudetto”.
Traguardi ottenuti con “gli occhi della tigre”, il mantra del presidente di quel Siena: Paolo De Luca, l’uomo venuto da Napoli per realizzare i sogni di una città calcisticamente vergine. “Viveva il calcio solo nel weekend e ci portava il suo entusiasmo e la capacità di parlare con ognuno del gruppo. È difficile racchiudere in poche parole cos’ha rappresentato. Ha saputo coniugare umanità e gestione aziendale. Una piccola realtà non avrebbe sopravvissuto a lungo senza una guida così forte”.
Valori e investimenti. E lui a guidare la carica. Numero 10 sulle spalle, il drappo di una città da portare in terre mai battute. Chi se non lui, con quell’aria e quell’espressione un po’ così che hanno a Genova e con quella potenza in entrambi i piedi propria solo dei più grandi. Fabio Capello lo definì “un incrocio fra Gigi Riva e Paolo Rossi” e lui non ci ha mai badato troppo, pensando solo all’incrocio verso cui indirizzare le sue parabole. Traiettorie impazzite, come quelle che lo portarono a Siena, dopo una carriera spesa fra Samp, Parma, Fiorentina e Lazio. “Fu una scelta logica da prendere. A Roma avevo giocato col contagocce. Dovevo guarire al meglio da un infortunio al ginocchio. Avevo necessità di capire se potevo ancora giocarmela a certi livelli. E in più, abitavo a Firenze. Restare in famiglia era un valore aggiunto”. Vita da pendolare e dubbi spazzati via dopo poche giornate: tripletta con l’Empoli alla terza giornata. Primi squilli di tromba di una parata appena agli inizi. “Fu subito feeling con l’ambiente. Non solo per i gol. La gente di Siena somiglia un po’ a quella di Genova: introversa, apparentemente scettica, ma generosa e leale quando prende confidenza. Conservo tuttora rapporti veri e loro mi hanno accettato mettendo da parte ogni campanilismo”.
Nessun problema se Chiesa non vive in una contrada. Spesso i grandi fantini del Palio vengono da fuori. Quello che conta è ciò che accade dentro l’arena. “Nessuno mi faceva pesare il fatto che avessi scelto di abitare a Firenze. Riuscimmo in grandi imprese. Al mio secondo anno, battemmo nel giro di tre giorni il Milan di Ancelotti in casa e la Roma all’Olimpico”. In entrambe le occasioni ci mise lo zampino. Due vittorie ottenute anche grazie al lavoro fatto da due uomini di fatica e qualità alle sue spalle: Mignani in difesa e Vergassola a centrocampo. Rispettivamente allenatore e vice del Siena che oggi ritenta la scalata. “Eh, gli manca un attaccante nello staff, magari ci vado io a dare un po’ di fantasia… Scherzi a parte, sono contento per loro e seguo con grande interesse la cavalcata dei bianconeri. La serie C è strana: il Livorno sembrava già partito e invece ora è tutto in ballo. E ora lo scontro diretto darà risposte importanti”.
Sfide così ne ha vissute tante con quella maglia. “Era il tempo delle quattro toscane in serie A, i derby erano all'ordine del giorno. A Livorno vincemmo una partita pirotecnica: 3-6. Pazzesca, ricordo che segnai anche lì”. Vero, ma quel giorno gli eroi furono Maccarone e Vergassola, autori di una doppietta. Un flash che forse attraverserà il vice di Mignani per pochi attimi prima della partita.
Ricordi, cassetti riaperti. Tre anni in doppia cifra e due in chiaroscuro.
Memorie, come il nome di un compagno di reparto di Enrico. “Ho un grande ricordo di Tore Andre Flo, il perticone norvegese. Un grande giocatore, di un’umiltà straordinaria, sereno e silenziosissimo”. Introverso, come i genovesi e i senesi.
O come l’immagine di un bambino che iniziava a guardare il mondo da una fascia, solo un po’ più defilato rispetto a ora. “Sì, Federico iniziò a Siena a fare il raccattapalle. E ha continuato finché non ho smesso. L’ha fatto anche a Figline, nelle mie ultime stagioni”.
Quel sottile passaggio da “figlio di” a “padre di” inizia a essere completo. Un passaggio di consegne fisiologico. Oggi Enrico lavora in federazione. Responsabile del centro territoriale di Firenze. Può godersi la crescita dell’ex raccattapalle ogni weekend al Franchi. Lo stadio di Siena porta lo stesso nome. Forse un giorno potrà vederlo pure in quel Franchi. Attori e spettatori. O viceversa. Questo però dipende soprattutto dalla sua vecchia squadra. Quella che con lui, non retrocedeva mai.
Credits Photo: Fabio Di Pietro