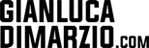Alla fine di una serata così, la ricerca di una spiegazione e di una ragione di fronte alle mille sfaccettature dell’accaduto appare quantomeno doverosa. Un po’ perchè si finisce per non crederci, un po’ perchè la partita racconta qualcosa che nel punteggio finale non si ritrova: un po’ perchè il Milan, dopo averla cercata, voluta ed ottenuta dentro e fuori dal campo, ha abbandonato l’Europa. Nel modo forse più incredibile e nella terra in cui, a mezz’ora di distanza dal “Georgios Karaiskakis”, è riuscito a scrivere due dei più bei capitoli della propria storia di successi.
Oggi, però, la realtà parla di qualcosa di diverso. Racconta di una gara contro l’Olympiacos divenuta teatro (greco) dell’assurdo, in una città dove l’arte ellenica e l’ideologia drammaturgica del secondo dopoguerra finiscono per unirsi, indissolubilmente, almeno per 90’: di una fragilità, tra campo e panchina, che va a ricalcare le orme di quell’insensatezza esistenziale post…”Finale di partita”. Non (solo) un’opera di Samuel Beckett, tra i massimi esponenti della condizione esistenziale precaria, ma anche triplice fischio su un’avventura che, doverosamente, avrebbe dovuto proseguire più a lungo. Interrotta, invece, tra un controsenso e l’altro.
Zero alibi: la perenne condizione imposta da Rino Gattuso al termine di ogni gara stagionale del suo Milan, mai tanto colpito da una tendenza all’harakiri come in questa stagione, come primo esponente pronto a metterci la faccia e scusarsi dopo una “figuraccia”. Lucidissimo e da chapeau nel post gara, meno nei 90’ del Pireo: un cambio difensivo a snaturare modulo e ambizioni, con Laxalt per Cutrone (e non Calhanoglu), un errore arbitrale a punirne la scelta. Paradosso che si abbina a quello del risultato da ottenere e difendere: vittoria, pareggio o anche sconfitta a disposizione, a meno di un K.O. da 2 gol di scarto tra 2-0 e 3-1. Il tabellino finale, specchio di una serata folle, racconta esattamente ciò che il mondo rossonero non avrebbe voluto vedere.
Soffrire più se stessi che gli avversari: il 2018/19 del Milan, tra un regalo e l’altro, prosegue pericolosamente così. Gestire senza grossi affanni per un’ora, crollare di fronte alla propria fragilità mentale nei trenta minuti successivi, sprecando a ripetizione: un errore o distrazione per compromettere traguardi e punti, l’incapacità di trovare un leader in grado di caricarsi la squadra sulle spalle anche nei momenti più complessi. Puntare su Gonzalo Higuain per centrare un quarto posto attualmente mantenuto, tentando di riconquistare la partecipazione in Champions, e uscire dalla porta accanto di un’Europa raggiunta, persa, ritrovata e poi abbandonata. Nel modo più incredibile.
E il parlare di sbagli altrui, in uno scenario simile, finisce in secondo piano. Decisivi e determinanti sì, così come non circoscritti alla sola serata ateniese, ma debole àncora cui appigliarsi di fronte all’impossibilità di superare un girone che al momento del sorteggio, dalle parti di Milanello, non poteva che essere definito certamente abbordabile. Tutto destinato a racchiudersi in un’unica serata, dal ”Finale di partita” folle, tra palloni gettati in campo e vani, confusionari assalti disperati. In un teatro (greco) dell’assurdo dove la Casa di carta, più che la coreografia dell’Olympiacos, ha finito per rappresentare la materia fragile di un Milan affondato in un mare di inattese difficoltà. Tanto apparentemente solido quanto internamente debole.