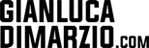Figlio di Ronaldo. Di nome Romário. Il Fenomeno e il Baixinho c’entrano poco con la sua storia, se non come nomi evocatori di sconfinato talento calcistico. Romarinho, però, ha fatto tutto da sé.
Tutto cominciò con un viaggio in treno verso Salvador, quando il Vitória decise di prenderlo, a soli 7 anni. Chissà se ancora oggi pensa ai sette pacchi di biscotti portati con sé, divorati più che per fame, per saudade. All’arrivo, alle lacrime. Di nostalgia per casa sua, di rimorso per la sua famiglia, tradita da quella stupida sensazione d’assenza che ti fa sentire nulla, se sei solo un bambino. Tradita dopo l’incredibile colletta per raccogliere i 150 euro che gli permettessero di comprare il biglietto per poter conquistare il sogno di fare del futebol la sua vita. Con un ritorno immediato, dopo sole due settimane. Se pensa ancora alla seconda opportunità, tre anni dopo. Ne aveva 10, le distanze minori, la squadra il São Paulo. Non disposta ad accettare che quel bambino volesse giocare a pallone e non fare i compiti, come tutti i bambini del mondo, ma solo un po’ di più visto il suo dono. Pensava solo al calcio, e fuori dal campo faceva i capricci. Altra caduta, altro abisso. Poi, uno spiraglio. Partire da Palestina, Stato di San Paolo, verso il mondo arabo vero, Dubai, città del suo destino, per uno stage con altri quindici ragazzi come lui. Occasione fallita, nessun club degli emiri disposto a investire su quella garotada. Ritorno a Palestina, Brasile, 12mila abitanti, due mesi al fianco della madre contadina. A imparare la calma. La pazienza di aspettare. Il maturare dei frutti, delle cose. Era il momento delle scelte: calcio o altro. Il Rio Preto, i pasti fatti solo di biscotti, yogurt e succo di frutta, l’allenatore che gli dava del fallito. Sembrava la fine prima che arrivasse il Bragantino. L’offerta mentre si allenava da solo a casa sua. Il Paulistão da rivelazione. L’offerta di prestito gratuito del Santos, la sua squadra del cuore, rifiutata. La proposta del Corinthians. Il debutto da titolare nel Clássico contro il Palmeiras. Il gol di tacco. La doppietta decisiva. L’insperata convocazione per la finale del torneo più importante del Sudamerica. Chissà se pensa ancora a quando Mauro Silva andò da quel ragazzino portato in Argentina quasi per caso, o forse, semplicemente, per destino: “Preparati, Tite sta per farti entrare”. “Finalmente”, rimuginava lui, “Ero stanco di mangiare merda da Série B. Qui è tutto più facile: ci sono più spazi”. Sette minuti in totale in Copa Libertadores, sufficienti per segnare con il cucchiaio al Boca a La Bombonera in finale. A Palestina scoppiò la festa: notte in bianco. Il fratello di Romarinho spaccò sedie e finestre per esultare. Il ricordo del treno verso il Vitória cancellato dal volo verso la vittoria della Copa Libertadores. Spuntarono cugini che non l’avevano mai neanche salutato, ammiratrici e amanti, una casa nuova per i genitori a San Paolo. Ma loro tornarono in campagna: troppa saudade, la stessa che aveva lui.
Cinque anni più tardi Romarinho fa ancora parlare di sé. Nell’anno di quella Copa Libertadores vinse anche il Mondiale per Club, l’ultimo successo sudamericano in quella competizione. E il Mondiale per Club lo vede protagonista anche quest’anno: veste sempre una maglia bianconera, stavolta quella dell’Al Jazira, squadra degli Emirati Arabi, il posto dove era stato scartato da ragazzino. Ha deciso la partita con l’Auckland City con una grande giocata individuale, stavolta un tiro da fuori e non un pallonetto; poi in semifinale contro gli Urawa Reds un assist geniale per Ali Ahmed Mabkhout per portare l’Al Jazira ad affrontare il Real Madrid in semifinale e rendere sempre più speciale il suo rapporto col torneo che lo ha portato sul tetto del mondo.
Romário Ricardo da Silva detto Romarinho, figlio di Ronaldo e nipote di Mário, che prende il suo nome dall’unione di quello di padre e nonno, scrive la storia. Senza essere il Fenomeno o il Baixinho.
di Tre3Uno3