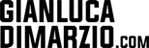No, non ce lo meritiamo. Il trentenne che piange con una cresta tricolore e la sua ragazza che lo copre con la bandiera. Il bambino che guarda il padre e chiede se abbiamo ancora una possibilità di andare al mondiale. No, piccolo, siamo fuori. E non è colpa nostra. Perché anche se fischiamo l’inno svedese in un momento di delirio ultranazionalista, rimediamo poco dopo, con l’applauso collettivo a Jacob Johansson, il cavaliere dell’apocalisse. Un suo gol all’andata ci fa piangere, ma quando lui esce in barella con la faccia fra le mani gli siamo vicini. Siamo fatti così. Ce la prendiamo con le istituzioni ma restiamo umani. Non ce lo meritiamo il triplice fischio dell’arbitro e il silenzio assordante che segue. Questo dolore è nostro, ma noi le abbiamo provate tutte per evitarlo.
L’Italia chiamò e noi abbiamo risposto. Come siamo abituati a fare nelle emergenze, come facciamo in prossimità dei disastri. In quei momenti in cui dimentichiamo il nostro orticello, la voglia di parlare male delle persone che abbiamo accanto. Di quelli che ci scavalcano sul lavoro o ci stanno antipatici. Fratelli d’Italia, mano sul cuore, una voce sola. L’abbiamo vissuta così. In 75mila in uno stadio, chissà quanti a casa. Sul divano con l’amico di sempre. Quello dei tempi delle superiori, quello con cui condividete sempre meno cose, a parte quelle che contano. Perché questa, per quella generazione inibita a credere in qualcosa, era molto più di una partita. Era darsi appuntamento all’estate, alle grigliate con le mogli a casa,ai momenti che ricordiamo prima degli altri. Era quella bandiera che prende polvere per anni fino a quei giorni in cui vale la pena di tirarla fuori. Quelle settimane in cui i terrazzi gridano chi sei. Tutti convocati: gli scettici, gli ipercritici, quelli che “è l’ultima volta che soffro così” e non vedono l’ora che arrivi la volta dopo. Gli ottimisti, i commissari tecnici, i complottisti e i disfattisti. Tutti con gli occhi su 11 ragazzi, messaggeri e protagonisti dei nostri sogni. Ci siamo affidati a loro. Come davanti a uno specchio, sperando che riflettesse la nostra voglia disperata di notti magiche, di estate. E niente, non è bastato.
Ci è tornata un’immagine impotente, di una squadra incapace di segnare un gol in 180’ alla Svezia, 25esima squadra del ranking mondiale. Guardiamo la loro festa, i loro sguardi increduli di chi ha fatto un’impresa, di chi ha una storia da raccontare. Quella notte a San Siro, chissà come si dice in svedese. L’epica dei vichinghi, come suona male. Abbiamo sperato fino alla fine nel nostro momento leggendario. Sul tiro di El Shaarawy, su un colpo di Immobile, sulla giocata di Florenzi. Ragione e irrazionalità. Ci siamo stretti quando abbiamo visto Buffon andare nell’area avversaria sugli ultimi corner. Speravamo nel miracolo, ci sono rimaste le sue lacrime. Uguali a quelle della ragazza che lascia San Siro col tricolore sulle guance ormai disfatto. La nazionale è di tutti, di Gigi che perde il suo sesto mondiale, della ragazza col trucco rovinato, di tutti noi che abbiamo un vuoto nel palinsesto mentale a giugno. Ci sono tanti colpevoli. Lo sanno loro, lo sappiamo noi. Tra chi si dimette, chi lascia e chi ancora non lo fa, questa serata perseguiterà sempre chi l’ha vissuta. Siamo ancora al funerale, puntare il dito ci fa sentire soltanto più soli. C’è una sola verità, purtroppo. Che mancano 5 anni al mondiale. E non è un errore, ma solo una conseguenza di questo film dell’orrore.
Claudio Giambene