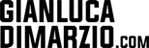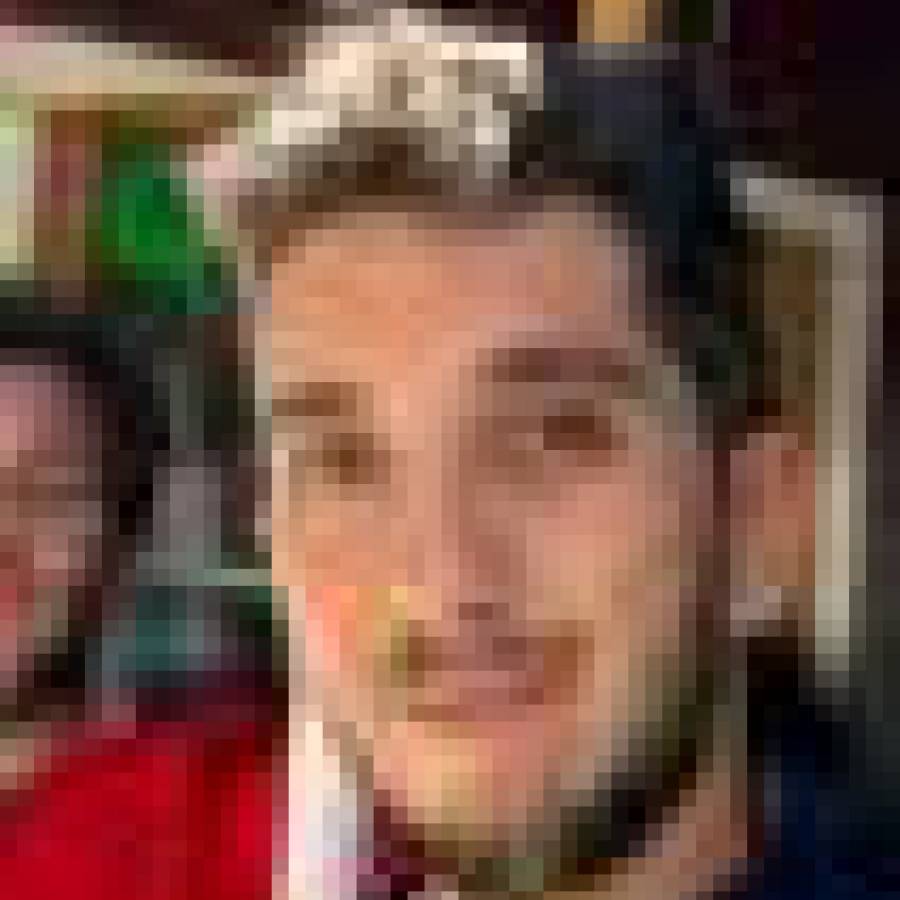Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò e fallirò meglio. Lo scriveva Samuel Beckett, se l'è tatuato anche Stan Wawrinka sul corpo, ma per Hector Cuper sembra ormai un mantra da ripetere a se stesso. È una maledizione quella che che si è abbattuta sulla carriera dell’allenatore argentino, con un denominatore comune: il numero 5. Cinque come le finali già perse in carriera. Due con il Maiorca, in Copa del Rey contro il Barcellona e in Coppa delle Coppe contro la Lazio. Una casualità, che si trasforma in "normalità" quando viene sconfitto in due finali consecutive di Champions League con il Valencia. In Grecia, poi, la sentenza finale: quinta finale persa alla guida dell’Aris Salonicco.

La maledizione del cinque, dicevamo. Come quel 5 maggio quando all’Olimpico di Roma si materializzò il dramma interista. Le lacrime di Ronaldo ed il volto di Massimo Moratti incredulo, con la Juventus campione d’Italia. Ancora un cinque, questa volta di febbraio e tre lustri dopo, lo ha visto perdere l’ultima finale, quella della Coppa d’Africa da tecnico dell’Egitto. L’hombre vertical, l’uomo tutto di un pezzo, si arrende nel post-partita di Libreville: “Ho perso di nuovo una finale, non voglio dire che mi sono abituato, ma non ho avuto molta fortuna con loro”.
“Trabajo, suerte y silencio” i suoi valori. Lavoro, tanto sul campo. Perché avere grandi campioni è importante, ma l’organizzazione lo è di più. “L’ordine migliora la vita”, così per le sue squadre. Tattiche e difensive, con poco spazio per la fantasia e tanto per l’organizzazione. La fortuna, quella che gli è mancata. Da allenatore non solo finali perse, anche tante altre occasioni per alzare un trofeo. Come nel Torneo di Clausura del 1994 sfumato con l’Huracan all’ultima giornata di campionato. Ma soprattutto la doppia semifinale di Champions League alla guida dell’Inter contro il Milan.

E poi il silenzio, lo stesso che regna prima dell’entrata dei suoi giocatori in campo, che carica sempre con una pacca sul petto. Poche parole, sguardo indecifrabile e impenetrabile, in panchina e fuori dal campo. Come ieri al termine dell’ultima finale persa, con un volto che non faceva trasparire nessuna emozione. Il calcio che dimostra come la distanza tra vittoria e sconfitta possa essere minima. Una questione di minuti, come il gol all’89’ di Aboubakar, o di undici metri, come nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Héctor ha fallito di nuovo, ma continuerà a provarci, per ripetere la gioia di quella Supercoppa di Spagna del 1998 contro il Barcellona, l'unica finale vinta in carriera.