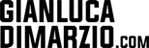Sono nato nel 1947, mio padre si chiamava Peter, mia madre non lo ricordo; il mio nome non ve lo dirò: ne ho avuti due ma il primo me l’hanno cambiato per questioni anagrafiche. Ho la palla sui piedi da sempre e la prima volta che l’ho calciata ho capito che l'avrei fatto per tutta la vita. All’inizio facevo pratica in casa, mi stendevano a terra una coperta verde (dopo la guerra erano molto diffuse quelle utilizzate dai militari e reperirle era facilissimo, così diceva mio padre); lo spazio era limitato ma la felicità no, quella era senza confini. Con il passare del tempo i campi si sono fatti reali e mi travolgeva l’entusiasmo al pensiero di provarli tutti. Ormai avevo una squadra e le persone che mi seguivano, anzi ci seguivano, non erano più soltanto i famigliari. Era bello averli tutti intorno ma il rapporto più speciale ce l’avevo con i più piccoli: ero la loro finestra su questo gioco fatto di linee, reti e distese di verde. Ero l’unico che li avvicinava ad un mondo che conoscevano solo attraverso radio e televisione, quando erano fortunati. La mia maglia da gara era la mia più fedele compagna: la prima che ho indossato è stata anche l’unica, l’ultima. I primi tempi ce le facevano a mano e ci concedevano di scegliere dettagli per il colletto o per le maniche, poi questo sport ha preso piede e hanno iniziato a produrle in serie le industrie. L’avevo sempre addosso la mia, così per scendere in campo mi sarebbe bastato un minuto; ma la cosa più assurda era che la tenevo anche di notte, in quella stanza buia e un po’ angusta dove dormivo. Non mi ci separavo mai. I miei giorni erano in funzione del pallone, mi svegliavo con la voglia di gonfiare quella rete che a me sembrava immensa, così come il campo, sul quale all’inizio ero impacciato e lento. Tiravo i palloni così fuori misura che ancora ricordo il vibrare delle transenne che ci circondavano quando giocavamo. Poi ho imparato a dosare la potenza, calciavo meglio di settimana in settimana e l’attacco è diventato la mia zona ideale, diciamo che potevo giocare solo lì. Nel ’70 la soddisfazione più grande: il Mondiale, poi gli Europei, le competizioni nazionali…e i premi ai migliori giocatori. Speravo di arrivare a Roma ’90 e ad Amburgo ’92, ma non è accaduto perché il mio sport ha subito una crisi irreversibile. In America e in Italia hanno provato a rilanciarlo, anni dopo, ma senza seguito. Per me era il più bello di sempre, ma non sembrava stare al passo con la modernità. Qualche affezionato per fortuna oggi (r)esiste: c’è un professore universitario italiano che vive in Corea, lo chiamano “il giocatore solitario”, sembra impossibile dato che il mio è uno sport di squadra, eppure si dice che riesca a dar vita a vere e proprie partite senza l’aiuto di nessun altro. Io non posso che sperare, perché è per merito di persone come queste che sopravvivo. E’ solo grazie agli ultimi amanti del gioco vero, reale e autentico che calcio ancora il pallone. Ora chi sono ve lo posso dire: mi chiamo Subbuteo.
Data: 23/10/2016 -
"Caro Subbuteo...". Il nostro viaggio nel mondo del gioco che compie 70 anni