Data: 23/01/2016 -
Bologna, Donadoni: "Rivera era grande perché era semplice: così si diventa idoli"





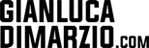
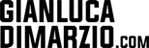


Data: 23/01/2016 -
Autore: Redazione


Tags:






