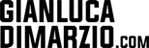Una carriera passata a lottare in mezzo al campo. Poi un ventennio sulle panchine inglesi a lavorare nell’ombra, mentre dietro le quinte combatteva il male di vivere. A volte nel modo sbagliato, altre con il vecchio piglio di quel numero 8 che non accettava sconfitte.
Cadere e rialzarsi, da sempre le parole d’ordine per Ray Wilkins. Questa volta però la seconda parte è sparita.
Il leone di Londra se n’è andato a 61 anni in un letto del St.George Hospital. Una settimana fa, un attacco cardiaco lo aveva fatto crollare a terra, facendogli battere violentemente la testa. Da quella caduta, non si è rialzato.
Oggi lo piange tutta l’Inghilterra. Per 84 volte ha difeso sul campo la sua patria, tre con la fascia al braccio. Al mondiale messicano dell’86 osservò da pochi metri la mano de Dios e la successiva discesa del “barrilete cosmico”. Era in panchina, chissà se quello slalom avrebbe avuto lo stesso epilogo con lui sul terreno di gioco. Perché quando il pallone rotolava, Ray metteva la maschera da duro.
Da ragazzino lo chiamavano Butch, soprannome sinonimo di durezza e caparbietà. È stato un inglese fiero, nei pregi e nei difetti. Qualche pinta di troppo ne aveva scalfito il fisico e aggravato quel male di vivere che si portava dietro. Una colite ulcerosa lo devastava quanto la depressione. Problemi affrontati coraggiosamente, senza arrendersi. Il suo cuore però soffriva: nel luglio scorso era stato in ospedale a farsi sistemare un doppio bypass. Neanche quello l’ha salvato.
Restano i ricordi. Da giocatore, visse giorni felici a Old Trafford con la maglia dello United a cavallo fra i ‘70 e gli ‘80. Nel 1983 una sua rete contribuì alla vittoria della FA Cup. Era arrivato a Manchester dal Chelsea, il club che ne ha segnato le tappe più importanti della sua vita. L’esordio nel ‘73, capitano a 18 anni, la promozione nella massima serie - non ancora ribattezzata Premier League - poi il ritorno da vice allenatore sul finire degli anni ‘90. L’esperienza di Ray per coprire le spalle di Gianluca Vialli, all’epoca allenatore emergente di una società che iniziava a pensare in grande.
Un matrimonio durato poco, un dualismo professionale proseguito al Watford: Vialli in panchina, Ray alle sue spalle. Si erano sfidati sul campo. In serie A: il primo con la maglia della Sampdoria, Wilkins con quella del Milan preberlusconiano. In una di quelle sfide, Ray aveva anche trovato il gol, uno dei pochi della sua vita da mediano. Tre stagioni in rossonero, fra l’84 e l’87, baluardo di un centrocampo tenuto in pugno insieme ad Agostino Di Bartolomei. Cerniera fra Mark Hateley e i quattro difensori che avrebbero scritto la storia pochi anni dopo. Troppo tardi per Ray, che era già emigrato altrove. Prima a Parigi, poi a Glasgow. Lì, con la maglia dei Rangers, è ricordato come una leggenda. A chiamarlo lì era stato Graham Souness, suo avversario di mille battaglie nei derby del Northwest contro il Liverpool.
Un biennio di vittorie domestiche, fra coppe e campionato, con la perla di un gol al volo contro i rivali cattolici del Celtic. Quanto basta per entrare nel cuore della gente di Ibrox.
Stessi sentimenti dei tifosi del Queen’s Park Rangers, ai quali ha regalato gli ultimi veri quattro anni di fatiche.
Poi si è seduto in panchina, ancora con la mentalità del mediano. Prima con Vialli, poi con Wise ma soprattutto accanto ad Ancelotti nel Chelsea capace di vincere FA Cup e Premier nel 2010. “Gli scorre il Chelsea nelle vene. Senza di lui non avremmo vinto niente”, disse di lui Re Carlo.
Purtroppo quelle vene non funzionavano più bene. Se n’era già accorto durante le ultime esperienze, da commissario tecnico della Giordania e da vice all’Aston Villa. Era diventato un opinionista di riferimento dei programmi sportivi. Fino all’ultimo giorno: mercoledì scorso era andato in onda poco prima dell’infarto.
Per l’ultima volta. Lascia una moglie, due figli e sette nipoti. È soprattutto per loro che Ray ha lottato nelle tenebre contro mali oscuri. A volte ha vinto, altre ha perso. Sempre a testa alta, come nelle battaglie a centrocampo.